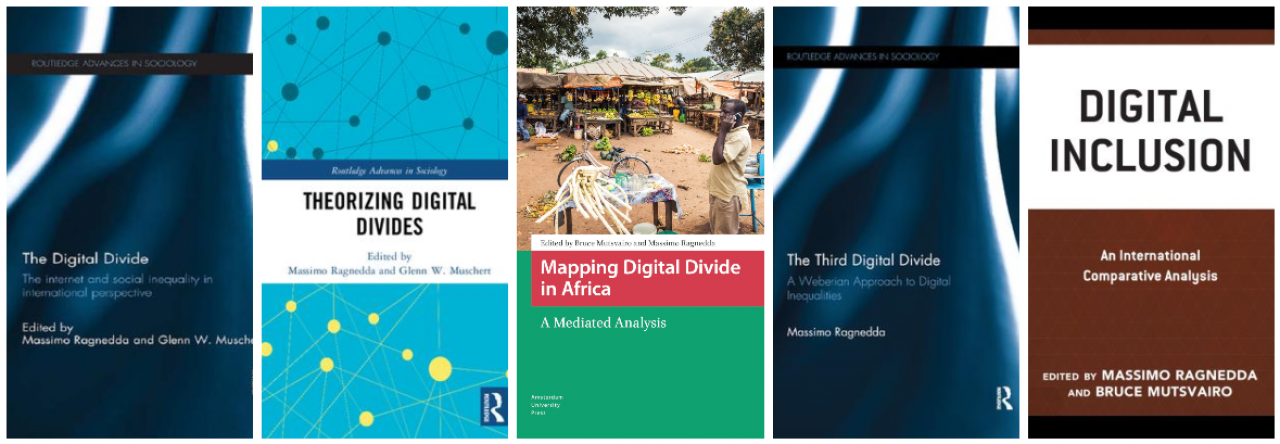di Massimo Ragnedda (Tiscali)
di Massimo Ragnedda (Tiscali)
Non sono un economista e faccio fatica a districarmi in questa marea di informazioni e dati che tutto dicono e nulla spiegano. Quando gli economisti e i mass media parlano della crisi sembrano parlare in codice per non farci capire. I mass media hanno il dovere di informarci, ma non lo fanno. So tutto dell’omicidio di Avetrana, della casa di Cogne, del delitto di via Poma, della strage di Erba, eccetera, e non so i nomi degli speculatori, chi comanda il Fondo Monetario Internazionale, cosa sono le agenzie di rating e soprattutto cosa guadagnano le banche centrali e da chi sono governate. Voglio i nomi e voglio conoscere i meccanismi, e voglio che siate voi economisti a spiegarcelo. Per esempio mi piacerebbe che spiegaste questo ai cittadini. La crisi finanziaria non è un fatto inevitabile e in balia delle forze irrazionali della natura; non è un terremoto o un’eruzione vulcanica: non è, insomma, un evento geologico, ma un evento previsto e prevedibile. Mi chiedo e vi chiedo: qualcuno ci guadagna da questa crisi? E se sì, chi? E poi: se qualcuno ci guadagna, non potrebbe essere lui il responsabile creando ad hoc la crisi per specularci?